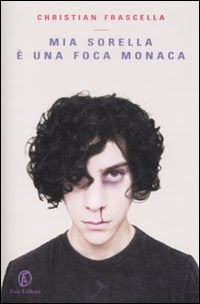Nel post precedente parlavo di
Cat Power e delle sue molte vite.
Anche io, come tutti, ne ho vissute tante. In una di queste, sono stata la moglie della Spia in versione ufficiale.
Che tradotto in parole povere ha significato, tra le altre cose, accompagnarlo a feste, ricevimenti, inaugurazioni, cene, colazioni, cocktail e cerimonie varie, sempre vestita in modo acconcio (leggi: da babbiona) a trascorrere il tempo evitando di ingozzarmi di vaccate e sostenendo conversazioni - nel migliore dei casi spesso insignificanti (quelle che gli inglesi, con sublime, secca concisione chiamano
small talks) e nel peggiore noiose da piangere - con persone con le quali, avessi potuto scegliere, nella maggior parte dei casi non avrei mai voluto nemmeno trovarmi in fila alla cassa del supermercato, tanto per dare un'idea.
Quella vita, che si è protratta per quasi dieci anni, dall'esterno avrebbe potuto apparire anche desiderabile, affascinante, esotica e per certi versi, ad essere sincera, lo è anche stata, a volte.
Ma poche persone hanno realmente compreso quanto poco potessi sentirmici a mio agio.
Quanto intensamente desiderassi non partecipare a quelle occasioni mondane.
Quanto mi sgomentasse, soprattutto i primi tempi, la prospettiva di ritrovarmi in mezzo a decine di persone più o meno sconosciute o, peggio ancora, note, ma alle quali mi legava un tenuissimo filo di frequentazioni assidue ma superficiali, costanti ma formali, che si mantenevano sempre entro i confini di quell'avvilente dimensione del
"Io e te faremmo volentieri a meno di essere a questa festa, ma facciamo lo stesso due chiacchiere compìte perché è quanto richiede l'etichetta in queste situazioni".
Quella vita mi ha insegnato molto, credo, su quanto le persone abbiano tutte, indistintamente, bisogno di essere ascoltate, su quanto poco siano abituate ad esserlo veramente e su quanto meno ancora siano 'allenate' ad ascoltare gli altri.
La mia personale strategia di sopravvivenza, elaborata dopo anni di coliti e timidezze feroci, fu invece proprio quella di ascoltare.
Più che cianciare del nulla, cosa che mi faceva sentire un'idiota o divorata dall'imbarazzo, ascoltavo con tutta l'attenzione che potevo concedermi in quella situazione.
Superato lo scoglio iniziale (terribile, come lo è per tutti i timidi), finivo spesso per appassionarmi.
Il mio interlocutore, invece, tutto preso dal racconto di sé, non si accorgeva nemmeno se fossi intelligente o scema, bella o brutta, interessante o spiritosa, ma se ne tornava a casa sicuramente convinto che fossi un ricettacolo di ogni cristiana virtù.
A parte rari casi di sociopatici, infatti, chi si sente ascoltato da te te ne sarà grato e tu, in cambio, trarrai la sensazione di aver fatto qualcosa di utile, o quanto meno di non dannoso, per la società.
Il che non ti salverà, sia ben chiaro, dal rischio di farti comunque ammorbare, a volte, da racconti noiosissimi sui più insignificanti dettagli di vite assai modeste come respiro, orizzonte e contenuti - e questo spiega le mie pur frequenti crisi di avvilimento, allora.
Ovviamente quella vita è stata in parte redenta da incontri significativi, anche affettuosi e stimolanti, con persone cui sono riuscita - spero - a dar veramente qualcosa di me, e non solo la mia educata attenzione per una sera.
Alcune di loro, benché non le veda e non le senta da anni (e non ne senta il bisogno, diciamolo pure), mi sono rimaste in qualche modo nel cuore.

Per un gesto di gentilezza autentica, magari durante una serata particolarmente pesante in cui avrei voluto scappare saltando a pie' pari le siepi del giardino e invece sono rimasta lì a sorseggiare vino cattivo in preda alla colite.
Oppure per uno sguardo fugace, brevissimo, di complicità e di ironia condivisa.
O per una parola detta con spontaneo calore, rivolta davvero a me e non al personaggio che in quel gioco fatuo cui pure dovevo giocare mi era stato assegnato.
Una di queste persone, un signore, la prima sera che venne a casa nostra per una cena cosiddetta
"di rappresentanza", arrivato questo dolce in tavola, per un momento si intenerì.
Mi chiese come fosse esattamente e, ascoltata la mia descrizione, concluse:
"Un dolce inusuale per una cena così, un dolce di casa".
Lo disse con tenerezza, con nostalgia (della moglie che lo attendeva a svariate migliaia di chilometri e dalla quale desiderava tornare? della bambina che aveva appena adottato con tanta fatica dopo mesi e mesi di burocrazia e incertezze? della sua mamma?).
Per me, lo disse con la voce giusta, quella che io volevo sentire in quel momento.
Dopo quella cena, quel signore sedette alla nostra tavola altre volte e furono tutte occasioni di incontro reale ed affettuoso, di allegro nutrimento del corpo e dello spirito.
Tutte le volte che preparo questo dolce, penso a quell'uomo, alla sua espressione quasi riconoscente quando ne assaggiò una fetta, all'intima condivisione che si creò, magicamente, intorno a quel tavolo tra persone che fino a quel momento avevano parlato, con civiltà e garbo, sì, ma anche con una certa educata ritrosia, soprattutto di lavoro e politica e si ritrovarono, invece, ad un tratto, a discorrere di figli e mariti, di mogli e ricette, di ricordi del liceo e di libri, di musica e gatti e a ridere spesso e volentieri, con gran gusto.
E mi dico che quella vita lì, che oramai è passata e a volte sembra quasi assumere i tratti sfumati e vaghi del sogno, non solo non è stata inutile, ma mi ha lasciato anche qualche gemma tra le dita.
Cose piccole, come questa.
Infinitamente preziose.
Cerco di non dimenticarlo mai.
Torta di mele con salsa toffee (da
Falling Cloudberries di
Tessa Kiros)
per una tortiera di 24 cm di diametro
3 mele
100 gr. di burro, a temperatura ambiente
200 gr. di zucchero
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
3 uova
200 gr. di farina 0
2 cucchiaini di lievito per dolci
1 cucchiaino di cannella (assente nella ricetta originale; per me è un riflesso condizionato: dove ci sono mele, non può non esserci della cannella)
60 ml (4 cucchiai) di latte
per la salsa toffee:
20 gr. di burro
115 gr. di zucchero
125 ml di panna
Preriscaldate il forno a 190°.
Imburrate e infarinate la tortiera, possibilmente di quelle a cerniera.
Sbucciate le mele, tagliatele in quarti. Da ogni quarto ricavate delle fette non troppo spesse.
In realtà, ad essere sinceri, io le taglio in modo sempre diverso. A volte uso la mandolina e faccio delle fettine sottili sottili, che si fondono quasi nell'impasto. Altre, invece, no. Regolatevi voi.
Come che sia, disponete queste fette nella teglia. Se siete bravi e avete pazienza, optate per il classico disegno a raggiera. Se siete impazienti e sciattoni come me, mettetele più o meno a casaccio, cercando di non sovrapporle troppo e di coprire i buchi.
Con le fruste elettriche sbattete insieme lo zucchero, l'estratto di vaniglia e le uova, fino a quando il composto non si sia schiarito e trasformato in crema.
Setacciatevi dentro la farina, il lievito e la cannella (se la volete usare).
Aggiungete anche il latte, mescolate con cura, indi trasferite il composto nella tortiera e cuocete per 35'-40' (prova stecchino).

Nel frattempo preparate il topping.
Mettete burro e zucchero in un pentolino e a fiamma media fate cuocere per 3'-4'.
Aggiungete la panna, all'inizio con cautela (attenzione agli sputazzamenti bollenti).
Abbassate il fuoco e cuocete per un altro minuto.
Liberate la torta dalla sua tortiera e versateci sopra un po' della salsa.
Il resto portatelo in tavola, magari in una bella lattiera, così che chi lo desidera possa aggiungerne altra.
Enjoy!
 Che gioia poter leggere questo libro e capire che non sono la sola ad essere una pedante in cucina!
Che gioia poter leggere questo libro e capire che non sono la sola ad essere una pedante in cucina!